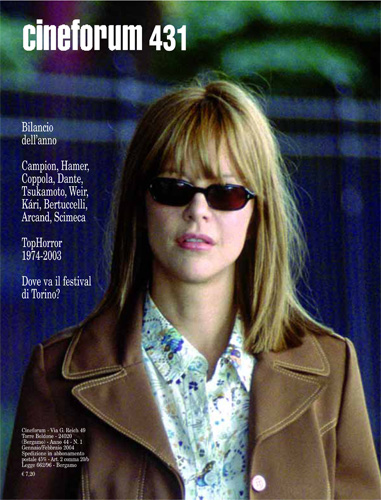Lost in Translation - L'amore tradotto di Sofia Coppola
Questa sera, su Rai Movie, alle ore 00:05 andrà in onda Lost in Translation - L'amore tradotto. Film del 2003 scritto e diretto da Sofia Coppola con Bill Murray e Scarlett Johansson. Riproponiamo alcuni estratti della recensione scritta da Matteo Bittanti che publicammo su Cineforum 431 (acquistabile qui)
In una delle scene più memorabili di quello che è, a tutti gli effetti, un instant cult nonché una delle cose più memorabili dell’anno appena concluso, Bill Murray/Bob Harris si esibisce in una struggente performance al karaoke (sì, persino migliore di quella di Cameron Diaz ne Il matrimonio del mio migliore amico). Murray prende il microfono («Lo so, è difficile») e canta un classico dei Roxy Music, «More than this»: «Like a dream in the night / Who can say where we’re going / No care in the world» («Come un sogno nella notte / chi può dire dove stiamo andando / non importa nulla nel mondo»). L’essenza del film sta tutta qui.
Lost in Translation racconta della ricerca disperata del senso nella terra del nonsense. Il titolo italiano, L’amore tradotto, è, manco a dirlo, clamorosamente fuorviante. L’opera seconda della Coppola è tutto fuorché una traduzione amorosa. È semmai il resoconto di uno smarrimento esistenziale. È una riflessione sul transeunte, l’effimero, il fragile. È un racconto impressionistico ed impressionante, che rimanda tanto a Godard quanto a Fellini (la cui Dolce vita è esplicitamente evocata e di cui Lost in Translation è, a tutti gli effetti, un omaggio: Tokyo la città simulata versus Roma la città eterna). Come C.Q. (2000) del fratello Roman, Lost in Translation è un omaggio al cinema degli anni ’60. […]
Murray (re)interpreta il personaggio che abbiamo imparato a conoscere ed amare. Bill Murray è un gigante (non solo nella scena dell’ascensore). Bill Murray è immenso. Bill Murray è il cinema. Raleigh St. Clair (I Tenenbaum, Wes Anderson, 2001), Mr. Herman J. Blume (Rushmore, Wes Anderson, 1998), Phil Connors (Ricomincio da capo, Harold Ramis, 1993)... Bill Murray è il cinema. Amaro e cinico.
Murray/Harris vuole semplicemente “sentire” qualcosa, qui ed ora, perché ha un buco enorme nell’anima e glielo si vede in faccia, è un buco davvero enorme. Murray vuole “provare” qualcosa. Non vuole morire, ma allo stesso tempo, non sembra nemmeno bramoso di vivere. Lascia Charlotte prima che possa innamorarsene. Bill Murray/Bob Harris, attore tra virgolette, solo ma non isolato. Alienato al punto che deve vedere il suo poster su un bus per ricordarsi chi è e cosa sta facendo. Bob esplora gli spazi giganteschi dell’hotel (non-luogo) mentre la moglie, dall’altra parte del mondo, sta rinnovando la casa (il luogo per definizione), ma a Bob non importa né dell’uno né dell’altro. Bob si è perso, per lui i luoghi non contano più nulla.
Ciò che rende Lost in Translation così dannatamente brillante – uno di quei film che vorresti non finissero mai, uno di quelli di cui provi nostalgia nell’atto stesso di guardarli perché sai che film così escono nelle sale una volta ogni cinque, sei anni e se vivi che so, settant’anni alla fine riesci a vederne al massimo una quindicina e la cosa, a pensarci bene, è deprimente – è il senso di melanconia che pervade le immagini, quel senso di evanescente tristezza che già si respirava in The Virgin Suicides (1999), l’opera prima della Coppola. […]
Lost in Translation è un racconto che è già ricordo: gli stessi personaggi sono perfettamente consapevoli di vivere il loro presente al passato. Celebra il desiderio di richiamare alla memoria un’esperienza liminale (il viaggio su un pianeta alieno, come Tokyo, per esempio). Lost in Translation sembra essere stato girato in uno stato di jet lag, ebbrezza da insonnia: gli attori sono smarriti in uno scenario che è al tempo stesso familiare e marziano. Gran parte dell’“azione” si svolge nel generico e monumentale Park Hyatt, struttura immensa nel cuore dell’astrale Tokyo. Un micromondo che ospita, tra le altre cose, una piscina, un ristorante francese, un bar americano, una clientela “internazionale e cosmopolita”. C’è tutto in Lost in Translation: Marc Augé e il Tati di Playtime, J.G. Ballard e Blade Runner, Prima dell’alba e le sale giochi popolate di personaggi bizzarri e postumani […]
Bob e Charlotte costruiscono una parentesi spazio-temporale fondata sul senso di umanità in una dimensione sociale disumanizzante. Una topografia delle emozioni nel deserto del reale. Questa è antropologia cinematografica. Del resto lo spettatore, scrive Giuliana Bruno («Rovine con vista. Alla ricerca del cinema perduto di Elvira Notari», La Tartaruga, 1995), è mobile e tendenzialmente femminile. Non è un voyeur, ma un voyageur. Viaggia nello spazio fisico, ma soprattutto nello spazio del vissuto. Lost in Translation non poteva che essere ambientato a Tokyo, città globale, generica e “noiosa” per definizione […]