Grasse città, magri boxeur
Il 10 luglio scorso, Jake LaMotta avrebbe compiuto cento anni. Il celebre pugile italoamericano, che di cartoni ne ha dati e ricevuti parecchi sia sul ring che nella vita, è stato biografato da Martin Scorsese nel 1980 in Toro scatenato (recensione di Giorgio Rinaldi sul n. 203, aprile 1981). Otto anni prima, il 26 luglio del 1972, usciva Città amara (in originale, Fat City), film pugilistico altrettanto significativo, e uno dei più belli della New Hollywood. A dirigerlo un giovanotto di sessantasei anni di nome John Huston. Tratto da un romanzo di Leonard Gardner, sceneggiato dallo stesso scrittore, come accade nelle opere di Huston è la poetica e sensibile narrazione delle vite, delle tribolazioni e della rassegnazione di gente scalcagnata votata alla sconfitta (poi, alla fine, ci si ritrova al bancone di un bar a bere una tazza di caffè). Maurizio Porro ha parlato del film sul n. 130, febbraio-marzo 1974, in una recensione che qui riproponiamo.
«Cineforum» n. 130, febbraio-marzo 1974
Scheda: Città amara, Maurizio Porro
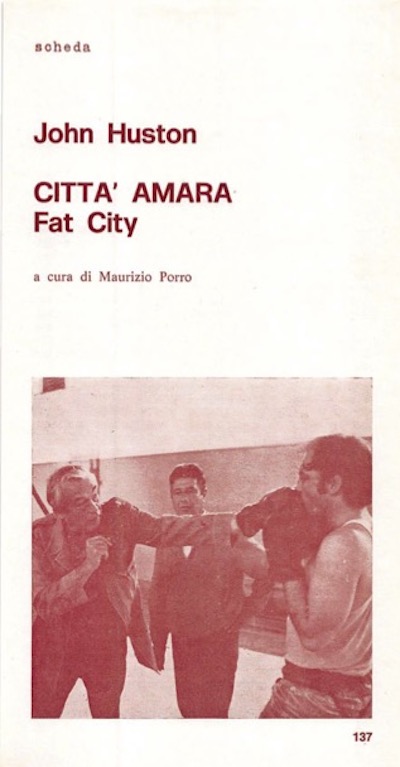 Fat City (intitolato in italiano, con leggera ma giustificata licenza poetica, Città amara dove l'amaro sublima il grasso ma toglie alla pellicola il sapore “unto”, del suo titolo originale) nasce sfortunato, nel senso che è una di quelle tipiche opere volute dall'autore contro i desideri imperanti della produzione. Huston è abilissimo nel dare un colpo al cerchio e uno alla botte: si fa ben volere dal box-office e proprio quando sembra un uomo diventato totalmente tranquillo sferra un pugno che ti resta a lungo nello stomaco. Un film dove l'azione è minima e l'introspezione è massima non può essere ben visto dai noleggiatori, guardinghi come pochi altri quando si trovano davanti a opere di vera qualità. Nessuno bada al fatto che Huston esprime tutto con i mezzi precipui del cinema. Eppure dovrebbe essere la cosa più importante.
Fat City (intitolato in italiano, con leggera ma giustificata licenza poetica, Città amara dove l'amaro sublima il grasso ma toglie alla pellicola il sapore “unto”, del suo titolo originale) nasce sfortunato, nel senso che è una di quelle tipiche opere volute dall'autore contro i desideri imperanti della produzione. Huston è abilissimo nel dare un colpo al cerchio e uno alla botte: si fa ben volere dal box-office e proprio quando sembra un uomo diventato totalmente tranquillo sferra un pugno che ti resta a lungo nello stomaco. Un film dove l'azione è minima e l'introspezione è massima non può essere ben visto dai noleggiatori, guardinghi come pochi altri quando si trovano davanti a opere di vera qualità. Nessuno bada al fatto che Huston esprime tutto con i mezzi precipui del cinema. Eppure dovrebbe essere la cosa più importante.
Fat City è un film sgradevole, se diamo per buona, almeno momentaneamente come ipotesi critica, la concezione imperante del gusto borghese. La borghesia è l'autrice del concetto del gusto medio. Un film dove i valori sacri della maggioranza (la famiglia, il lavoro, perfino il pasto) vengono non tanto dissacrati (a questo ormai ci sono tutti abituati), ma ignorati. Fanno parte di un bagaglio sociologico che non interessa. La verità sta dentro ma oltre le cose, nell'apparire squallido e quotidiano di questa cittadina infelice, nell'ombra del tramonto perenne, nel gestire inutile di questi personaggi, nel buio di ritrovi che non sono mai accoglienti, in una angoscia che compenetra tutta la vicenda. Sarebbe fin troppo semplice parlare di angoscia esistenziale. E anche sbagliato. Né Billie né Ernie sono divorati da problemi metafisici; sono persone che si lasciano vivere perché la società entro la quale sono immersi non concede loro alternative di altro tipo. Tutto ciò, questa carica oggettiva di critica nei confronti dell'organizzazione della vita, Huston non lo esprime quasi mai con il dialogo, che è una forma classica d'espressione del dramma borghese, che per dare l'incomunicabilità ricorre quasi sempre alla comunicazione del verbo. Tutta questa ansia dilacerata, tutta questa tristezza di vivere, tutta questa rinuncia sono date e poste al pubblico unicamente con i mezzi tipici del cinema: con il taglio dell'immagine, con il ritmo del racconto, con la musica che interviene propizia e al momento giusto, con l'interpretazione, con il montaggio che non toglie e non aggiunge nulla che non sia assolutamente indispensabile.
Fat City è un film di grande saggezza cinematografica e la prova di una grande misura d'autore, oltre che del suo stile e della sua classe. Parlare di stile può essere in un certo senso limitativo, perché lo stile è proprietà che più volte viene usata anche contro la buona riuscita della pellicola stessa. La proprietà non è più un furto, tanto per fare un esempio di cui si parla, è un film di stile, ma sbagliato, dove proprio lo stile concorre a ingarbugliare le acque già torbide dell'ideologia.
Di ideologia probabilmente John Huston non vuole neanche sentir parlare. La sua poetica è quella della realtà come gli si è sempre presentata davanti agli occhi, come il padre l'ha raccontata, come l'ha osservata nei lunghi viaggi a zig-zag su è giù per gli States. Particolare non trascurabile, lo stesso Huston fece, da giovane, il pugilatore, conobbe personalmente alcuni degli eroi che qua e là menziona nel film. Ha avuto modo insomma di padroneggiare la materia, nel senso che la conosceva a fondo. Ma tutto ciò non lo ha portato alla facile denuncia, al tuonar profondo del profeta che si scaglia con veemenza contro un particolare lato della vita che egli ben conosce. Huston ha fatto di più. Ha inserito questa sua critica (sempre espressa in termini cinematografici, ripetiamo), ha immesso questo suo piccolo inferno (che forse ma non per forza è anche personale) in un contesto che lo riconosce e lo fa suo giacché è la dialettica interna e globale delle cose che lo interessa, non il suo apparire parziale.
Scopriamo così che il mondo del pugilato in Fat City non è in fondo una presenza determinante. È parte di un tutto che già è sbagliato per conto proprio, che può provocare solo una catena di effetti sconquassati. Ma neppure incita il regista verso l'analisi politica della società, verso la rinuncia a credere alle forze linde di una democrazia che ha come risultato quello di incastrare giovani uomini in una specie di morsa da cui non è possibile uscire, giusto perché non si sa chi è stato a chiudere le sbarre così abilmente.

È in questo senso che Fat City non è neppure un film sportivo, ma un grosso affresco dove la società intorno è già morta; dove non si può più credere che la famiglia o il tepore della casa possano essere l'antidoto alla dissolutezza della vita consociata; dove non è solo il diritto al lavoro ma anche il diritto all'esistenza a essere messo in discussione. Ci sono certamente alcune battute del dialogo (ma poche) che possono sembrare il manifesto ideologico di tutto ciò. C'è il vecchio manager che, all'inizio, scoperto il potenziale talento del giovane, lo annuncia dicendo:«E poi non è neppure un negro». Ma non è il razzismo che viene preso specificamente di mira.

C'è sempre il manager che a un certo punto parla all'incirca così: «Le perdiamo tutte le giovani promesse, o vanno a sposarsi di fretta o finiscono in guerra». Ma non è neppure la guerra, come alternativa “vitale” del sistema che ha visto morire in Vietnam migliaia di giovani e ne ha visti migliaia di altri ritornare distrutti nella psiche, a essere messa in precisa discussione. C'è Billy, nel finale, che dice all'amico, mentre sorseggia il caffè, «Un giorno ti risvegli e ti trovi così», additando il vecchissimo cameriere che sembra prossimo alla morte. Ma non è il problema dell'organizzazione della vecchiaia. Fat City è tutto ciò in un insieme dialettico che evita le secche del conformismo retorico per adagiarsi nel ritmo lento e preciso della saggezza dolorosa di chi conosce a fondo le cose e le conosce dal di dentro. Bastano poche immagini a rendere l'ambiente dove vivono e agiscono i protagonisti: pochi rari squarci di case, di vie, di bar dal malvagio odore, di juke box consumati dall'uso, di piselli in scatola rovesciati sul piatto a tiepida cottura. Ciò che risulta essenziale è vedere come l'uomo (sia Billy sia Ernie, due misure generazionali dello stesso fallimento) reagisca a ciò che gli sta intorno, alla insostenibile situazione del “non-essere”.
Anche sul tema del lavoro Huston non si sofferma con caparbia ostentazione (eppure c'era la possibilità e sarebbe stato facile anche se cialtronesco accettare l'invito): gli bastano invece pochissime immagini a rendere l'umiliazione di questo lavoro povero, saltuario, mal retribuito. Un piccolo scuotimento dell'albero e abbiamo capito tutto. C'è una tristezza di fondo che compenetra uomini e cose. Già fin dall'inizio, quando vediamo il nostro “vecchio” (dalla sua stessa voce sapremo solo verso la fine che non ha ancora trent'anni) disteso sul letto, in mutande, che non sa che cosa fare, che non può scegliere, sappiamo che siamo di fronte a un uomo stanco, a un non-eroe. E quando vediamo la ragazzina (che anela alla convivenza familiare) disputare nell'ombra serale, seduta in macchina, sul futuro della casa, sul ménage matrimoniale, sappiamo che anche lei, come Ernie che cadrà nella trappola, è una donna che non può scegliere che le cose sbagliate perché l'imposizione del sistema è questa. Ci sono i piccoli malviventi organizzati che truccano gli incontri, che combinano match e poi neppure accompagnano i loro campioni fino al ring, ma non è neppure questo l'aspetto che Huston prende di petto. Solo nella scena finale, dove l'uso dell'immaqine fissa, dopo mille utilizzazioni da scartare torna nella sua purezza espressiva, sentiamo quei due poveretti comunicare (e non parlare) di cose serie, essenziali, del loro fallimento, della morte, della vecchiaia che sopraggiunge al galoppo mentre meno te lo aspetti. Ma anche questo è reso per immagini, attraverso il cine-occhio del regista che, identificandosi con i protagonisti, osserva gli avventori notturni di un bar macilento, col biliardo in stato di avanzata decomposizione.

Certamente Billy ed Ernie fanno ancora parte di una società organizzata, pur nella presunta devianza di almeno uno dei due. Billy infatti vive alla giornata, ma sa di essere condizionato da coloro i quali alla giornata non vivono e che, proprio per questa ragione, gli puntano contro la morale benpensante del reale che deve essere razionale. E, a suo modo, Billy accetta le regole di questa equivalenza, almeno nella misura in cui si esprime il suo rifiuto. C'è una consapevole amarezza nei vedersi emarginato dal convivio, ma non c'è disprezzo verso gli altri, non c'è accusa ideologica in senso stretto. Dall'altra parte, dalla parte estrema di chi invece ha troncato davvero ogni legame, c'è la vita irrazionale del tutto permesso e tutto concesso. Ci sono (è un film che ritorna spesso alla memoria) i killers della luna di miele. L'unica “soluzione”, spettacolarmente ufficiale del dramma di Billy è nel fatto che egli sia dedito al bere, secondo la poetica romantica che vuole l'alcool come antidoto ai dolori dell'esistenza. E Huston dà psicologicamente per buona questa ipotesi, senza però mai contraddire la purezza della sua esposizione, senza mai fare della morale spicciola sugli effetti nocivi dell'alcool. Tanto per intenderci non vediamo quasi mai Billy in stato di totale ubriachezza; lo vediamo forse subito prima o subito dopo, mentre si avvia o mentre si scioglie dall'incubo del bicchiere. Ma anche quando prepara quella angosciosa e sfortunata “cenetta” alla sua donna, è lei a essere più fuori dalla realtà, lei che non riesce ad andare a sedersi a tavola, lei che non tiene in mano il piatto e non porta il cucchiaio alla bocca.
Se mai c'è una interpretazione realistica del personaggio-Billy, è quando si parla della psicologia del boxeur intorpidito da questa professione che uccide gli stimoli e i riflessi. Ecco che allora vediamo, leggendo attentamente il film, il nostro non-eroe che non riesce ad appoggiare un pacco su uno scaffale perché la dimensione della distanza gli si fa opaca; che non riesce a chiudere una maniglia; che si fa cadere la roba di mano. Osservazioni piccole e non insistite, che distanziano comunque il film dal dramma veristico anche quando sarebbe plausibile ci cadessero dentro. Insomma, non c'è la pietà romantica dell'autore verso il suo personaggio: Huston non drammatizza con il pianto il senso della sconfitta. Se la parola non fosse velata da interpretazioni ambigue e da significati tristi, vorrei dire che Huston guarda la realtà in modo virile, dove però virile significa oggettivo e forse tragico. Una tragicità sistematica. Billy ed Ernie sono vecchie conoscenze, due dei tanti, non certo gli unici, sconfitti dalla vita giorno dopo giorno, pur proseguendo in due direzioni opposte, manovrando con insensata stupidità le poche armi che hanno a disposizione, le poche qualità che permetterebbero loro di raggiungere il medium civile per entrare nell'uovo chiuso della società che si oppone nello specchio.

Ma non c'è pietismo per loro neppure intorno, nei personaggi marginali, in quelli che dovrebbero essere compagni di sventura. La donna, quando ritorna il suo amato nero, non si fa scrupolo di cacciare Billy fuori dalla porta senza neppure dargli la buonasera; lo stesso Ernie, una volta sposato e dopo aver prolificato a dovere, fa finta di non riconoscere il vecchio compare, dal quale era stato aiutato all'inizio; la ragazzina che si fa impalmare e che convola a giuste nozze non ha neppure rapporto con gli altri perché lei è, nella sua mostruosità morale, un personaggio inserito. Il vecchio allenatore, quando Billy si allontana (e non c'è dubbio che questa volta va via sul serio e per sempre) cerca di farlo tornare indietro, ma lo fa con entusiasmo frenato, senza volontà, dicendogli soltanto che sarebbe finito sotto una macchina.
Intorno a questi uomini manca dunque una volontà onesta per vivere insieme e manca ovviamente anche l'esigenza superiore, la credenza in un benessere totale, in una giustizia suprema, in una onestà extra-temporale, in una dignità al di là dell'apparenza. L'esistenza, da chiunque sia condotta, dagli oppressi come dagli oppressori, si riduce soltanto a una lunga sequenza di fenomeni dei quali non riusciamo mai a ricordare la causa. Vediamo gli effetti, ma non sappiamo chi sia mai il motore agente. Per questo il “mezzo-cinema”, nel contesto della fenomenologia, è tanto bene espresso da Huston, proprio perché esso è il modo e lo strumento più peculiarmente adatto a dare questo senso di indigenza fisica e morale, di acquiscenza a ciò che vediamo e sentiamo, momento dopo momento.
Non esiste una “summa”, non esiste un ripensamento, non esiste l'organizzazione della vita, al di là della pura riflessione sulle percezioni (il bicchiere di whisky dà l'impossibilità di combattere; l'astinenza produce invece il risveglio delle forze fisiche). È quasi un film empirico, nella misura in cui rifiuta ogni significato che non sia reale e immediato. E il taglio del racconto, il montaggio, concorrono a evidenziare questa sensazione, senza che mai si aggiunga una parola di troppo, senza che mai sfiori il sospetto di una abilità che è conscia di essere tale.

