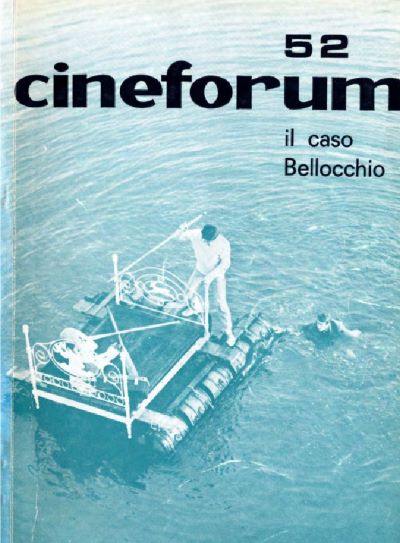All'inizio del bel libro-intervista autobiografico Stanley e io, Emilio D'Alessandro ricorda quando, non ancora autista di Stanley Kubrick, aveva portato sua moglie a vedere Il dottor Stranamore, aspettandosi entrambi una commedia spensierata, data la presenza di Peter Sellers, e rimandendo invece turbati perché il film raccontava la Fine del Mondo. Il recentissimo Oppenheimer di Christopher Nolan, sulle origini della Bomba, fu preceduto a suo tempo da The Beginning or the End, storia semidocumentaristica del Progetto Manhattan girata quasi “a caldo” nel 1947, con Hume Cronyn nei panni di Oppenheimer e Brian Donlevy in quelli del generale Groves. Sulla Fine del Mondo nucleare si tornerà nei primi anni 60 (il già citato Dottor Stranamore, Il giorno dopo la fine del mondo eccetera), quindi ancora negli anni 80 (Wargames). Del 1964 è A prova di errore di Sidney Lumet, di cui riproponiamo la recensione scritta da Sandro Zambetti, futuro direttore della rivista, e pubblicata su «Cineforum» n. 52, febbraio 1966.
«Cineforum» n. 52, febbraio 1966
Scheda
A prova di errore
Sandro Zambetti
 È chiaro che il film rappresenta sostanzialmente un monito contro i rischi di un conflitto nucleare e un drammatico richiamo al senso di responsabilità di tutti coloro che possono e devono ridurre tali rischi, non ultima l'opinione pubblica, stimolata a rendersi conto della minaccia e a far quindi sentire ai responsabili il peso delle proprie preoccupazioni. La motivazione di questo grido d'allarme e l'indicazione delle cause da rimuovere per far migliorare una situazione così esplosiva, non sono però altrettanto chiaramente espresse.
È chiaro che il film rappresenta sostanzialmente un monito contro i rischi di un conflitto nucleare e un drammatico richiamo al senso di responsabilità di tutti coloro che possono e devono ridurre tali rischi, non ultima l'opinione pubblica, stimolata a rendersi conto della minaccia e a far quindi sentire ai responsabili il peso delle proprie preoccupazioni. La motivazione di questo grido d'allarme e l'indicazione delle cause da rimuovere per far migliorare una situazione così esplosiva, non sono però altrettanto chiaramente espresse.
Dal fìlm, infatti, emergono via via almeno tre tesi al riguardo. La prima indica nelle macchine il pericolo maggiore. L'uomo sta creando apparati tecnici sempre più complessi e perfezionati, al punto che questi possono ormai sfuggire al suo controllo e agire indipendentemente dalla sua volontà. Una didascalia piuttosto ridicola avverte, alla fine della proiezione, che l'errore ipotizzato nel film non è possibile, perchè i sistemi di controllo sono tali da escluderlo a priori: ma è ovvio che non basta questo rassicurante discorsino conclusivo per cancellare tutta l'impostazione dell'opera.
La seconda tesi è strettamente connessa alla prima e fa risalire alla scienza la principale responsabilità. Il progresso scientifico appare come basato su leggi proprie, staccate da qualsiasi contesto etico e necessariamente indipendenti da ogni considerazione umana, leggi analoghe a quelle dell'evoluzione biologica. Il progresso scientifico porterebbe quindi di per se stesso all'eliminazione dei deboli e alla sopravvivenza dei più forti.
La terza tesi fornisce invece un'interpretazione “politica” della situazione. Il pericolo deriva direttamente, e soprattutto, dall'atmosfera di sospetto che grava sul mondo e dalle barriere di incomprensione e di sfiducia erette fra i due maggiori sistemi politico-economico-sociali.
Le tre tesi possono evidentemente coesistere, perchè c'è del vero in ognuna di esse. È indiscutibile, infatti, che le macchine siano giunte a un punto tale di perfezione e di autonomia da poter sfuggire al controllo dell'uomo: l'ipotesi di un mondo dominato dalle macchine, del resto. è frequente nelle previsioni più pessimistiche sul futuro dell'umanità e riflette la reale tendenza a una sempre più accentuata automazione del lavoro. Altrettanto reale la tentazione di fare della scienza una disciplina a sè stante, quasi una filosofia di quel regime tecnocratico che sembra vada instaurandosi sia a Occidente che a Oriente.
Ciò non toglie che al fondo di tutto vi sia la volontà dell'uomo e che la stessa possibilità di concretizzazione delle due ipotesi precedenti dipenda dalle sue scelte politiche. È quanto viene messo in rilievo soprattutto nella seconda parte del film, attraverso i colloqui tra i due capi di Stato: qui il discorso di Lumet si fa chiaro e coerente, dando all'opera una fisionomia precisa ed essenziale. Ma gli echi delle affermazioni precedenti restano e rischiano di confondere il significato sostanziale del film, oltre a rivelare una certa dose di incertezze nella visione del regista e nel suo atteggiamento di fronte al tema trattato.

Analoghe incertezze si notano in alcuni particolari tutt'altro che trascurabili. Mentre le tendenze aggressive vengono concentrate nel personaggio dello scienziato, i militari appaiono tutti schierati – a eccezione del colonnello Cascio, indicato però come un caso patologico – contro la guerra: il militarismo risulta così una forza di pace, il che è decisamente discutibile e piuttosto ambiguo. Inoltre nella conversazione del colonnello Grady con un collega, prima del decollo da Anchorage, vengono rievocati con accenti commossi i tempi in cui era «il pilota a portare l'aereo» e non viceversa e in cui contava soprattutto “il fattore personale”: ne vien fuori una sorta di nostalgia per le guerre “tradizionali” che contrasta parecchio con l'impegno pacifista del film.
Le incertezze fin qui rilevate si ritrovano puntualmente negli squilibri della realizzazione, riassumibili soprattutto in quelle che potremmo chiamare le cadute teatrali di un'impostazione televisiva. È evidente, infatti, come il regista tenda a dare al racconto il tono di una trasmissione “in presa diretta” innestata improvvisamente in un normale programma della televisione. Così, l'inizio ha del documentario-inchiesta sul sistema difensivo americano e l'incidente che provoca il primo allarme sembra interromperne il regolare svolgimento, dando via libera all'incalzare degli awenimenti, mantenuti entro l'unità di tempo. Vien fatto di pensare, per esempio, alla tragica fine di Oswald, ucciso proprio davanti alle telecamere che ne stavano riprendendo la traduzione alle carceri di Dallas, dopo l'assassinio di Kennedy.
Ma è proprio in questa prima parte che si nota maggiormente il procedere del film su una specie di doppio binario: da un lato l'asciutta descrizione documentaristica degli ambienti (il comando strategico di Omaha, il Pentagono, la base di Anchorage) dove si svolgerà la vicenda; dall'altro lo sforzo inteso a dare una consistenza psicologica a determinati personaggi. Questo secondo obbiettivo è perseguito con una stringatezza di notazioni che non inceppa troppo il ritmo descrittivo per quanto riguarda il generale Black e il colonnello Grady: ma lo stesso non si può dire per il colonnello Cascio e per il professor Groteschele, dietro ai quali il movimento della macchina da presa ristagna in scene di forzata e faticosa spiegazione dei rispettivi caratteri (la visita del colonnello alla casa del padre ubriacone, lo “show” oratorio dello scienziato durante il ricevimento, con la fumettistica appendice della nevrotica in cerca di emozioni che vuoi farsi sedurre da lui).

In seguito queste parentesi si fanno sentire di meno, pur senza scomparire del tutto (il colpo di scena teatrale della ribellione del colonnello Cascio; l'insistenza sulle esibizioni di fanatismo del professor Groteschele; il suicidio finale del generale Black, con il richiamo a effetto al sogno iniziale), mentre va imponendosi il meccanismo di suspense, abilmente montato attraverso il rapido alternarsi dei luoghi d'azione ed efficacemente contrappuntato dalla concitazione drammatica delle consultazioni fra i vari personaggi.
Si potrebbe osservare che la costruzione assume, appunto, un carattere di tensione meccanica, rischiando di esaurirsi nella ricerca di effetti e motivi. Ma la cosa ha una sua giustificazione intima nel fatto che il film mira proprio a esprimere, fra l'altro, la minacciosa realtà dell'ingranaggio – la corsa agli armamenti, la spirale del sospetto, il progresso scientifico volto essenzialmente a scopi distruttivi – in cui il mondo rischia di essere preso e stritolato. Una struttura narrativa, quindi, che può anche risentire di determinate regole spettacolari, ma risponde essenzialmente a una esigenza espressiva, traducendola con notevole funzionalità. Il meccanismo, insomma, è nei fatti e nelle prospettive del nostro tempo, così come sono viste e interpretate dall'autore, per cui non è fuor di luogo che esso si rifletta nella strutturazione del film.
Semmai qualche riserva va avanzata per quanto riguarda l'equilibrio fra questo elemento fondamentale e l'altro, che pure il film introduce e che ha un'importanza non meno determinante: quello della riflessione sull'ingranaggio, la valutazione politica dei fatti, la posizione dell'uomo di fronte alla gran macchina cui tende a ridursi tutta la civiltà moderna e della quale l'apparato militare non è che il riassunto esemplificativo.

Tutto ciò è affidato emblematicamente al personaggio del Presidente americano, che in effetti riesce a rendere con notevole incisività il richiamo alla responsabilità dell'uomo e l'affermazione della necessità fondamentale di superamento dell'“equilibrio del terrore”, sia attraverso il suo isolamento nel bunker sotterraneo della Casa Bianca (l'individuo solo con la propria coscienza, il problema delle scelte di fondo, che si pone per ognuno di noi, contro le tendenze e gli impulsi alla massificazione), sia attraverso il gioco serrato dei primi piani, durante i colloqui telefonici con il Premier sovietico. Qui ha un ruolo determinante anche il tono della fotografia – in precedenza un po' ondeggiante fra la funzionale ricerca di effetti allucinanti, come nel sogno iniziale e nella presentazione della centrale strategica, e le pause di anonima correttezza – che, nella crudezza spietata dell'illuminazione e nella violenza del contrasto fra i bianchi e neri, concretizza efficacemente l'esasperata drammaticità della situazione e la tremenda elementarietà del dilemma fra pace e guerra. Ne esce un discorso piuttosto chiaro ed essenziale, che corregge l'incertezza stessa delle premesse e finisce col dare al film un significato preciso. Ma ciò non toglie che proprio questo discorso possa risultare come attutito dalla maggior suggestione esercitata degli elementi di suspense: un difetto di equilibrio fra le varie componenti del film, insomma, che ne indebolisce l'economia complessiva e rischia di farne confondere il senso autentico.
Tale possibilità è peraltro recuperata dal film con l'introduzione di un altro elemento, quale secondo termine necessario a creare il dramma: l'atmosfera di sospetto, la barriera della sfiducia reciproca. È questo, in sostanza, l'avversario contro cui devono battersi le forze della pace. Un avversario di ripiego, che lascia nel vago le cause e le responsabilità e rende un po' generico il discorso, ma che vale comunque ad animare dialetticamente la linea tematica del film.
L'altro termine del contrasto è naturalmente rappresentato dal personaggio del Presidente americano (e dell'invisibile Premier sovietico, potremmo dire, dato che i due costituiscono in pratica un unico personaggio: «Nè io, nè lei vogliamo la guerra»), al quale fa da contrappunto la figura dell'interprete, riflettendo i sentimenti dell'uomo comune di fronte al potere politico e alle minacce di guerra. Affidando l'interpretazione del Presidente a Henry Fonda, si poteva cadere nel cliché, visto che la parte dell'americano progressista (in politica, come in Tempesta su Washington e L'amaro sapore del potere, o anche su altri piani, come ne La parola ai giurati) sembra ormai sua per regola. Ma la sobrietà e l'impegno di questo attore riescono a fargli superare le tentazioni gigionistiche del ruolo fisso e a centrare i dati essenziali del personaggio nel variare delle situazioni. Qui le incertezze del momento, il peso tremendo della responsabilità e la tensione morale verso un rapporto più umano tra i popoli trovano in Henry Fonda la più lucida personificazione, attraverso l'estrema misura dei gesti e il trattenuto tormento dell'espressione.

Sidney Lumet, dal canto suo, ha scavato a fondo in questa materia espressiva con la funzionalità dell'ambientazione e con l'incisività della fotografia, sia – a questo secondo riguardo – con la crudezza dell'illuminazione sia con la sapiente composizione dei primi piani attorno a quel telefono che rappresenta realmente il filo a cui sono appese le speranze dell'umanità. Si aggiunga il ritmo incalzante del montaggio che lega la figura presidenziale al precipitare degli eventi e si potrà rilevare come le parole messe in bocca a questo personaggio (e al suo interlocutore russo) prendano evidenza da tutti gli elementi del linguaggio cinematografico, giungendo veramente a esprimere il significato fondamentale del film: «La colpa è nostra come vostra, che ci siamo affidati alle macchine. Siamo noi i responsabili, come di tutto quello che succede»; Andiamo avanti per la stessa strada?»; Dobbiamo dire ai nostri popoli che questo non succederà più»; Ma lo crede possibile, con la barriera che ci divide?»; «L'abbiamo costruita noi»; «Noi scontiamo il sospetto reciproco, ma bisogna abbattere la barriera: è la fine, se non abbiamo un po' di fiducia»).
Non si tratterà di una grande scoperta né di un eccezionale approfondimento delle cause da cui discende la minaccia alla sopravvivenza stessa dell'umanità, ma è un monito nobilmente civile e politicamente realistico, che ha il merito di farsi sentire con drammatica evidenza, riscattando le incertezze ideologiche e le incoerenze di linguaggio rilevabili in alcune parti del film.